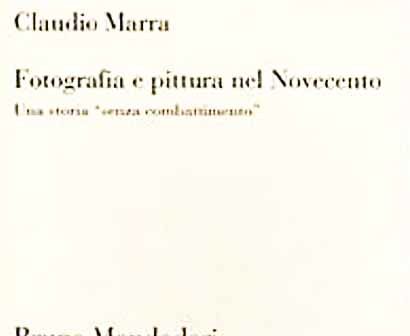Le riflessioni sul Camp, dedicate ad Oscar Wilde e scritte in forma d’appunti, danno a Sontag un’improvvisa notorietà: definendo questa forma di sensibilità “inconfondibilmente moderna”, questo gusto snob per l’artificio e l’eccesso, “distintivo di riconoscimento tra piccole cricche urbane”, come una sorta di moderno dandismo, che afferma l’esistenza di “un buon gusto del cattivo gusto”, la scrittrice colpisce immediatamente l’immaginazione di un pubblico che va al di là degli addetti ai lavori.
Le riflessioni sul Camp, dedicate ad Oscar Wilde e scritte in forma d’appunti, danno a Sontag un’improvvisa notorietà: definendo questa forma di sensibilità “inconfondibilmente moderna”, questo gusto snob per l’artificio e l’eccesso, “distintivo di riconoscimento tra piccole cricche urbane”, come una sorta di moderno dandismo, che afferma l’esistenza di “un buon gusto del cattivo gusto”, la scrittrice colpisce immediatamente l’immaginazione di un pubblico che va al di là degli addetti ai lavori.
Lo stile epigrammatico asciutto – che sempre caratterizzerà i suoi scritti, sia pure in una forma più distesa e riflessiva – si presta in quel momento ad un largo successo, ma anche a letture superficiali, che faranno etichettare il saggio come un trattato sull’estetica omosessuale e ne ridurranno i molti spunti possibili allo slogan: “è bello, perché è orribile”.
In realtà, in quelle argomentazioni c’è molto più; c’è il preludio del sistematico attacco che l’intellettuale americana avrebbe sferrato contro la critica tradizionale – da lei tacciata d’eccessivo intellettualismo – nella raccolta di saggi pubblicata l’anno dopo.
Se, infatti, negli appunti sul Camp si era limitata a descrivere un particolare gusto, e ad affermare che il gusto “governa ogni libera reazione umana, usando l’aggettivo ‘libera’ in contrapposizione all’aggettivo ‘automatica’”, e che “la sensibilità dell’alta cultura non ha il monopolio della raffinatezza”, con il suo “Against interpretation” si sposta più decisamente verso una “estetica dei sensi”.
Proclama la necessità di una lettura immediata, non ermeneutica ma “erotica” dell’arte: “ciò che è importante ora è riscoprire i nostri sensi. Dobbiamo imparare a vedere di più, ad ascoltare di più, a sentire di più”; queste asserzioni vengono recepite da molti come un tentativo di appropriarsi della rivoluzione sessuale per trasformarla in teoria estetica. E siffatta teoria viene applicata indifferentemente a testi letterari o artistici nel senso più ampio e vario: da Artaud ad Harpo Marx, da Sartre ai romanzi di fantascienza.
Gli interessi di Sontag, infatti, sin da allora sono variegati, e la inducono a soffermarsi su ogni genere di comunicazione contemporanea, indagandone l’impatto sulla società.
In una serie di saggi, dapprima pubblicati su “The New York Review of Books”, decide di indagare “certi problemi, estetici e morali, posti dall’onnipresenza delle immagini fotografate”. Ne verrà fuori nel ’71 il libro “On Photography”, pietra miliare nella riflessione sul linguaggio fotografico.
Fino ad allora gli studi sull’argomento erano stati pochi, e punto di riferimento nell’indagine sontagiana sulla fotografia è sicuramente Walter Benjamin, la cui analisi sociologica viene da lei ampliata e superata, mettendo oltretutto in luce le contraddizioni, provocate dall’attrito fra la sensibilità surrealista, soffusa d’ironia, e i principi moralisti, marxisti e brechtiani, dell’autore tedesco. Di Benjamin, Sontag rivela pure la passione di collezionista di citazioni, che “sembra una versione sublimata dell’attività fotografica”, in quanto quest’ultima è vista come un modo di collezionare indiscriminatamente immagini; surreale, perché crea duplicando il mondo “una realtà di secondo grado, più limitata ma più drammatica di quella percepita dalla visione naturale”: una realtà parallela, attraverso la quale si ha un’illusoria sensazione di conoscenza e di potere.
Come Benjamin, fra l’altro, Sontag cita Atget quale precursore del surrealismo fotografico, per il suo “atteggiamento inflessibilmente egualitario di fronte a qualsiasi oggetto”, e per la predilezione verso soggetti marginali e bizzarri, tipica della corrente artistica promossa da Breton. E prende in esame l’opera di August Sander che – mentre agli occhi del tedesco, grazie alla contemporaneità rispetto al suo saggio, appare soprattutto carica di significato politico, perché sposta l’attenzione sulla funzione sociale piuttosto che estetica della fotografia – per l’intellettuale americana è rappresentativo di un interesse nuovo, neutrale e “pseudoscientifico”, verso il volto umano, scelto non più perché oggetto di celebrazione, o di curiosità verso le miserie e le stranezze (a tal proposito, fa riferimento anche a Diane Arbus), ma scelto con un intento che “partiva dal corretto presupposto che la macchina fotografica non può fare a meno di rivelare i visi come maschere sociali”.
Riguardo al valore della fotografia come ambiguo strumento di conoscenza, la scrittrice rimarca l’idea benjaminiana dell’opportunità della didascalia, “che”, com’egli afferma, “include la fotografia nell’ambito della letteralizzazione di tutti i rapporti di vita, e senza la quale ogni costruzione fotografica è destinata a rimanere approssimativa”. Riprende inoltre anche l’assunto che l’immagine fotografica non è solo tramite di comunicazione, ma anche “bene di consumo”, rilevando che “una società capitalistica esige una cultura basata sulle immagini. Ha bisogno di fornire quantità enormi di svago per stimolare gli acquisti e anestetizzare le ferite di classe, di razza e di sesso”.
Non soltanto “oppio dei popoli”, tuttavia, la fotografia trova pieno riscatto già in Benjamin come medium capace di allargare il nostro “inconscio ottico” e la nostra ricettività visiva e, di conseguenza, la possibilità di comprendere. In Sontag arriva infine ad essere risorsa contro il nostro sempre più acuito “senso oppressivo della caducità di ogni cosa”: le immagini consumano ma, in qualche modo, rigenerano la realtà, divenute esse stesse reali. A questo punto urge, però, una “ecologia delle immagini”.
Non diversamente da quello che era avvenuto negli scritti precedenti, in “On Photography” la scrittrice esamina l’argomento trattato in una molteplicità d’aspetti, qui difficili da esaurire, proponendo una personale visione antidogmatica.
©CultFrame 07/2005
LINK